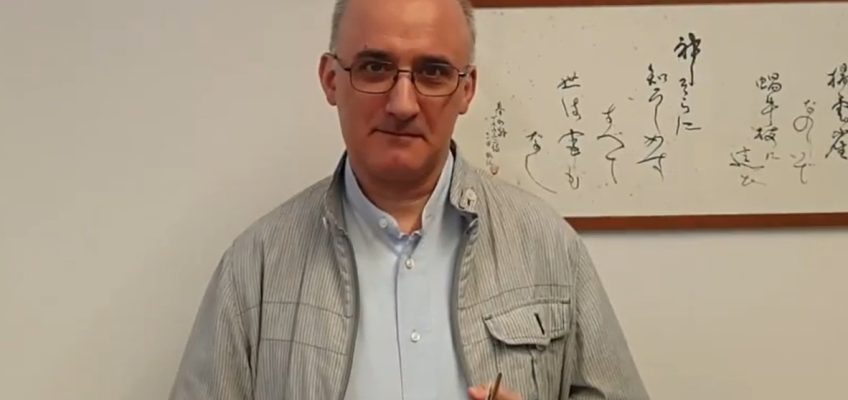Si chiama “Mizu Ippai”, letteralmente “bicchiere d’acqua piena” il centro di ascolto in cui presta servizio padre Marco Villa, missionario del Pime che si occupa degli hikikomori, persone che, volontariamente e liberamente, decidono di vivere – e talvolta di morire – nella più completa solitudine
Ripubblichiamo l’articolo che L’Osservatore Romano del 28 ottobre 2023 ha dedicato alla missione di padre Marco Villa, a firma di Antonino Iorio
«La paura di confrontarsi, di doversi conformare alle aspettative della società; questo spinge gli individui a praticare hikikomori. Un giovane che ogni tanto viene nel nostro centro di ascolto, ripete spesso che è la società ad offrire le migliori condizioni e possibilità di vivere senza affrontare lo stress del lavoro e del confronto con gli altri». Così padre Marco Villa, sacerdote del Pime, il Pontificio istituto missioni estere, riassume in poche righe il complesso fenomeno dell’hikikomori, un termine che in lingua giapponese significa “stare in disparte” e che nell’immaginario comune sta a indicare quelle persone che, volontariamente e liberamente, decidono di isolarsi dalla vita sociale.
Arrivato nel Paese del Sol Levante all’inizio del nuovo millennio, padre Marco dal 2009 presta servizio nella diocesi di Saitama, suffraganea dell’arcidiocesi di Tokio, a poco meno di mezz’ora di treno dalla capitale. È qui che dal 2012 il missionario italiano coordina il centro di ascolto “Mizu Ippai”, letteralmente “bicchiere d’acqua piena” che offre supporto e sostegno a quanti vivono nella condizione di hikikomori.
A segnare un prima e un dopo nella lunga vita missionaria di padre Villa, sicuramente lo tsunami che nel marzo del 2011 ha colpito il nord-est del Giappone, concausa del disastro nucleare di Fukushima e di uno degli eventi più traumatici della storia recente del Paese. Da questo cataclisma e da una riscoperta fragilità dei rapporti umani nel cosmopolita gigante asiatico, ecco partire una nuova missione evangelizzatrice del sacerdote italiano iniziata nella città di Koshigaya, nella prefettura amministrativa di Saitama, vera e propria bed-town, città dormitorio, alla periferia di Tokyo con oltre 300 mila abitanti e nemmeno un edificio di culto cattolico.
Su indicazione dell’allora vescovo, monsignor Marcellino Daiji Tani e in collaborazione con il Pime, viene aperta quella che ancora oggi è la sede del centro di ascolto che, grazie all’aiuto di quindici volontari, presta soccorso e offre assistenza a quanti sono colpiti da disagi relazionali.
«Non è facile – continua padre Marco – fare una stima veritiera di quanti vivono in questa condizione. In generale si inizia a parlare di hikikomori quando una persona interrompe i legami con il mondo esterno per almeno sei mesi continuativi».
Stando alle ultime statistiche sarebbero non meno di un milione e mezzo, pari all’ 1,5% dell’intera popolazione, gli individui che in Giappone vivono isolati da tutto e da tutti; principalmente di sesso maschile e sotto la soglia dei 40 anni.
Il fenomeno, che già trova terreno fertile in una predisposizione culturale nipponica che accentua e estremizza un’adesione quasi plastica a codificati modelli di vita, è stato ulteriormente aggravato dalla recente pandemia che ha causato una forzata e involontaria reclusione domestica con una brusca interruzione dei contatti umani.
Ecco allora che dopo l’epidemia sanitaria sembra acuirsi quell’epidemia sociale che, nel proprio piccolo, il centro di ascolto “Mizu Ippai” cerca di arginare con incontri settimanali di supporto: mangiare in compagnia, conversare e distribuire pasti caldi e amorevoli. Un rapportarsi con il prossimo che molto spesso è l’unica “medicina” possibile per chi si trova a vivere un’esperienza di hikikomori, che da soggetto in esilio, riscopre il tesoro delle relazioni interpersonali, nonché l’essere individuo unico e irripetibile, connubio di forza e fragilità, e non necessariamente anonimo ingranaggio di una società sterile e appiattita oltremodo sulla produttività e sui successi personali assunti a unico termometro di valore.
Per ottimizzare tempi e risorse, mai sufficienti per un agglomerato urbano dalle dimensioni spaventose, un calendario ben preciso scandisce il lavoro dei volontari che si suddividono in attività non solo all’interno, ma anche all’esterno del centro missionario come le visite periodiche alle stazioni ferroviarie del circondario, sempre più non-luoghi dove la frenesia della routine quotidiana rende ancora più invisibile quanti silenziosamente chiedono aiuto, anche solo con uno sguardo.
Gesti semplici, ma mai banali e atti concreti di una Chiesa missionaria che a Oriente vede riconosciuti e apprezzati, sempre di più, gli sforzi compiuti da quanti operano per il bene del prossimo con passione e vera dedizione.
«La Chiesa in Giappone è come una goccia in un grande mare, ma nonostante questo è generalmente stimata. Non sono poche le persone che quando decidono di uscire da una condizione di hikikomori, vengono a bussare alle porte delle nostre chiese. Trovare un ambiente sano e persone sensibili che hanno esperienze simili in famiglia o presso conoscenti; trovano parole e gesti di speranza, trovano anche l’occasione di sperare», spiega padre Marco che nei tanti anni di servizio ha visto anche gli effetti estremi della solitudine e dell’abbandono affettivo.
Estremo epilogo dell’hikikomori, il kodokushi: la morte in solitudine che colpisce quelle persone che dopo giorni, se non addirittura settimane, vengono ritrovate cadavere in quelle abitazioni elette a rifugio da una vita opprimente. Così la storia di Keiko, deceduta a 60 anni con l’unica compagnia di un gatto, quella di Sho-chan, in passato appartenente alla yakuza, la mafia giapponese, e pure rimasto solo e senza conoscenti e quelle di tanti altri sfortunati si intrecciano in un comune destino causato da quel malessere figlio dell’insensibilità emotiva della modernità.
Il kodokushi è ormai così frequente da non fare nemmeno più notizia in televisione o suoi giornali che, forse per pudore, forse per abitudine, ormai ignorano quei ritrovamenti fortuiti dovuti più all’esecuzione di sfratti o di provvedimenti amministrativi che al reale interessamento di familiari o vicini di casa. Sovente sono gli ufficiali giudiziari o i dipendenti delle ditte di trasloco a fare la macabra scoperta; nessuna indagine, nessuna inchiesta per quello che viene semplicemente registrato come l’ennesimo, forse inevitabile, caso di kodokushi.